Carre 9
giugno 53 a.C. Roma perde le sue aquile e scopre di non essere la sola padrona
del mondo. Storia di una disfatta tra la fine della Repubblica e la nascita
dell’Impero degli imperi. Il lento abbandono dell’illusione del dominio sugli
spazi infiniti segna la supremazia storica su ogni epopea
IL TOPO
E L’ELEFANTE
 Vietnam, dalla guerra
combattuta e persa dagli Stati Uniti, è anche una metafora per indicare la
sconfitta imprevedibile di una perfetta macchina bellica contro tecniche di
guerriglia, in territori non convenzionali. Il topo contro l’elefante, e il
topo vince. Vietcong è il
guerrigliero che morde e scappa, è il topo che vince.
Vietnam, dalla guerra
combattuta e persa dagli Stati Uniti, è anche una metafora per indicare la
sconfitta imprevedibile di una perfetta macchina bellica contro tecniche di
guerriglia, in territori non convenzionali. Il topo contro l’elefante, e il
topo vince. Vietcong è il
guerrigliero che morde e scappa, è il topo che vince.  Una certa storiografia
farebbe risalire un primo esempio di questo genere alla terribile sconfitta
inferta dall’esercito dei Parti, guidati del generalissimo Rostam Surena-Pahlavi, alle
legioni romane di Marco Licinio Crasso.
Un vero disastro che tuttavia non pregiudica il destino dei Romani, ma ne
influenza le linee d’azione in politica estera e militare. Roma comincia a
comprendere che la sua esistenza non si fonda sull’eterna conquista ma
sull’amministrazione “politica” della sua grandezza: non un imperialismo
indefinito ma una struttura imperiale che ruota attorno all’idea di Stato,
diritto, economia, riforme e comunità sociale; sopravvivendo così ai “capricci”
del despota di turno, e segnando in modo indelebile, anche dopo il suo declino,
lo sviluppo del mondo.
Una certa storiografia
farebbe risalire un primo esempio di questo genere alla terribile sconfitta
inferta dall’esercito dei Parti, guidati del generalissimo Rostam Surena-Pahlavi, alle
legioni romane di Marco Licinio Crasso.
Un vero disastro che tuttavia non pregiudica il destino dei Romani, ma ne
influenza le linee d’azione in politica estera e militare. Roma comincia a
comprendere che la sua esistenza non si fonda sull’eterna conquista ma
sull’amministrazione “politica” della sua grandezza: non un imperialismo
indefinito ma una struttura imperiale che ruota attorno all’idea di Stato,
diritto, economia, riforme e comunità sociale; sopravvivendo così ai “capricci”
del despota di turno, e segnando in modo indelebile, anche dopo il suo declino,
lo sviluppo del mondo.
SURENA
E CRASSO, LE AQUILE PERDUTE E LE TESTE MOZZATE
 La battaglia è dominata dall’intelligenza
tattica di Surena che lega storicamente il suo nome alla consacrazione delle
aquile (insegne militari romane) strappate al suo avversario, appropriandosi
così di un potente simbolo di vittoria. Ma chi è? Dignitario partico della
famiglia dei Suren è l’uomo più potente dell’Impero dopo re Orode: “Surena o, meglio, il Surena,
qualifica di una specie di presidente della corte suprema partica depositaria
del compito di designare il re tra gli aventi diritto alla successione, era un
giovane di trent’anni con l’abitudine e l’aspetto tipici delle persone del suo
rango: fasto pomposo e ingombrante nelle vesti, capelli inanellati e profumati
e il solito bagaglio di concubine al seguito. Particolari che si compongono in
un’immagine alquanto debosciata non raccomandabile in un generale che si
appresta ad affrontare le nostre legioni, ma che costituiscono un contrasto
affascinate quando siano accompagnati da intrepida spregiudicatezza, fantasia
rapida e percezione precisa delle situazioni”. G. Antonelli, Il libro nero di Roma antica, p.46.
La battaglia è dominata dall’intelligenza
tattica di Surena che lega storicamente il suo nome alla consacrazione delle
aquile (insegne militari romane) strappate al suo avversario, appropriandosi
così di un potente simbolo di vittoria. Ma chi è? Dignitario partico della
famiglia dei Suren è l’uomo più potente dell’Impero dopo re Orode: “Surena o, meglio, il Surena,
qualifica di una specie di presidente della corte suprema partica depositaria
del compito di designare il re tra gli aventi diritto alla successione, era un
giovane di trent’anni con l’abitudine e l’aspetto tipici delle persone del suo
rango: fasto pomposo e ingombrante nelle vesti, capelli inanellati e profumati
e il solito bagaglio di concubine al seguito. Particolari che si compongono in
un’immagine alquanto debosciata non raccomandabile in un generale che si
appresta ad affrontare le nostre legioni, ma che costituiscono un contrasto
affascinate quando siano accompagnati da intrepida spregiudicatezza, fantasia
rapida e percezione precisa delle situazioni”. G. Antonelli, Il libro nero di Roma antica, p.46.
Un personaggio dall’immagine non certo
asciutta come l’essenzialità romana: “Il comandante partico sfoggiava un lusso
orientale destinato ad impressionare sudditi e nemici. Nei suoi spostamenti
privati portava sempre mille cammelli con i cavalli e duecento carri di
concubine, e per la scorta mille cavalieri corazzati e un numero ancor maggiore
di cavalleggeri: in totale, con lui non vi erano meno di diecimila uomini tra
cavalieri, servitori e schiavi”. G. Traina, La
resa di Roma – 9 giugno 53 A.C, pp.58-59.
Così carnevalesco il suo ambiente ideale
quanto invece sostanziale e vincente la sua strategia: “Le sue truppe composte
esclusivamente di catafratti e di arcieri a cavallo non superavano le 10.000
unità. Di fronte ai 35.000 Romani potrebbero sembrare poco numerosi. Ma,
nell’aver limitato il contingente dei suoi squadroni, Surena ha dato prova
oltre che di audacia anche di genialità strategica. In questo modo infatti ha
semplificato il problema dei rifornimenti, ha acquistato maggiore mobilità e ha
evitato la confusione derivante dall’assieparsi in campo di sterminati corpi di
cavalleria”. G. Antonelli, Cit.,
p.46.
Una strategia non sconosciuta ai Romani ma,
in quella circostanza, forse un po’ troppo fiduciosi nella sola forza d’urto
delle legioni: “In realtà… usavano sia la cavalleria pesante (anche se non
corazzata), sia quella leggera, poiché gli assalti della cavalleria potevano
ancora essere molto efficaci contro corpi di fanteria male organizzati. In particolare,
la mancanza delle staffe non impediva gli assalti della cavalleria contro la
cavalleria nemica, specialmente se questa era leggera e non corazzata. Inoltre,
è praticamente certo che era stata ideata una tattica la quale in pratica
permetteva alla cavalleria di sconfiggere anche corpi di fanteria bel
organizzati: si trattava dell’uso combinato della cavalleria pesante (armata di
lance) e di quella leggera (composta da arcieri a cavallo). Questo metodo fu
usato dai Parti, che con il loro esercito di cavalieri distrussero le sette
legioni che Crasso… Tale tattica, basata sulla classica combinazione di armi da
lancio e forze d’urto, prevedeva l’impiego di un’enorme quantità di frecce
scagliate dagli arcieri a cavallo contro le file dei Romani, mentre i lancieri
li costringevano a rimanere in file serrate, minacciando di sferrare una carica
(o un vero e proprio attacco), ed esponendoli così più facilmente al lancio
delle frecce”. E. N. Luttwak, La grande
strategia dell’impero romano, p.84-85.
Surena geniale, rivoluzionario ma non più
fortunato del suo nemico romano perché finisce ucciso dal suo re per l’invidia
suscitata, dopo aver allestito “una parodia di trionfo, facendo sfilare per le
vie di Seleucia un prigioniero somigliante a Crasso, con una veste regale
femminile, ammaestrato a quanti lo chiamavano Crasso e generale; davanti a lui
marciavano i trombettieri e alcuni dei littori a cavallo di cammelli: ai fasci
erano appese delle borse e alle asce erano legate le teste dei romani, mozzate
di recente”. A. Frediani, I grandi
generali di Roma antica, p.274.
 Crasso invece è uno degli uomini più ricchi e
potenti di Roma tra proprietà terriere, speculazioni, miniere e schiavi. Un
uomo capace di accumulare denaro in ogni modo: “…Era stato favorito , nell’ereditare
il patrimonio familiare, dalla uccisone dei parenti più stretti per mano dei
sicari di Mario.
Crasso invece è uno degli uomini più ricchi e
potenti di Roma tra proprietà terriere, speculazioni, miniere e schiavi. Un
uomo capace di accumulare denaro in ogni modo: “…Era stato favorito , nell’ereditare
il patrimonio familiare, dalla uccisone dei parenti più stretti per mano dei
sicari di Mario. Inoltre aveva
sposato la vedova di suo fratello, soprattutto per evitare che l’asse dei beni
si disperdesse tra molti aventi diritto… Questo calcolo… non gli sarebbe
bastato per fare il salto di qualità a cui aspirava se non fosse stato
integrato dai proventi delle spoliazioni con cui si è distinto durante la
dittatura di Silla, con la
conseguente appendice delle proscrizioni… Con la sua avidità è riuscito a
scandalizzare perfino il suo capo che quanto a cinismo predatorio vanta un
livello a dir poco superlativo se non imbattibile… Aveva capito che le
costruzioni edili, in una città in cui la popolazione cresce in modo
esponenziale, per via degli immigrati provenienti, in cerca di fortuna, da ogni
paese del Mediterraneo, potevano diventare autentiche miniere d’oro… A Crasso,
quando arrivava in ufficio, il primo documento che i suoi impiegati
sottoponevano era il mattinale degli incendi scoppiati in città durate la
notte. Su queste informazioni impostava la sua strategia di accaparramento e di
espansione. A Roma, si sa, gli incendi e i crolli di case di ogni tipo non
fanno neanche più notizia. Crasso è stato uno dei maggiori usufruttuari di
questi continui disastri e dei drammi relativi”. G. Antonelli, Cit., pp.35-37.
Inoltre aveva
sposato la vedova di suo fratello, soprattutto per evitare che l’asse dei beni
si disperdesse tra molti aventi diritto… Questo calcolo… non gli sarebbe
bastato per fare il salto di qualità a cui aspirava se non fosse stato
integrato dai proventi delle spoliazioni con cui si è distinto durante la
dittatura di Silla, con la
conseguente appendice delle proscrizioni… Con la sua avidità è riuscito a
scandalizzare perfino il suo capo che quanto a cinismo predatorio vanta un
livello a dir poco superlativo se non imbattibile… Aveva capito che le
costruzioni edili, in una città in cui la popolazione cresce in modo
esponenziale, per via degli immigrati provenienti, in cerca di fortuna, da ogni
paese del Mediterraneo, potevano diventare autentiche miniere d’oro… A Crasso,
quando arrivava in ufficio, il primo documento che i suoi impiegati
sottoponevano era il mattinale degli incendi scoppiati in città durate la
notte. Su queste informazioni impostava la sua strategia di accaparramento e di
espansione. A Roma, si sa, gli incendi e i crolli di case di ogni tipo non
fanno neanche più notizia. Crasso è stato uno dei maggiori usufruttuari di
questi continui disastri e dei drammi relativi”. G. Antonelli, Cit., pp.35-37. Non gli basta. Militarmente cresciuto,
appunto, sotto l’ala di Silla ma con all’attivo solo la sconfitta di Spartaco nella rivolta degli schiavi
non ritenuta gloriosissima, è roso da un ambizione politica cieca che lo
distruggerà:
Non gli basta. Militarmente cresciuto,
appunto, sotto l’ala di Silla ma con all’attivo solo la sconfitta di Spartaco nella rivolta degli schiavi
non ritenuta gloriosissima, è roso da un ambizione politica cieca che lo
distruggerà:
 “La sua maggiore sfortuna fu quella di confrontarsi con Cesare e Pompeo: dove gli altri due triumviri si distinguevano per
genialità e carisma, lui si comportava con la consueta arroganza
dell’aristocratico. Carenza che gli impedì di creare quell’empatia necessaria
per assicurare la necessaria coesione di un grande esercito”. G. Traina, Cit., pag.14.
“La sua maggiore sfortuna fu quella di confrontarsi con Cesare e Pompeo: dove gli altri due triumviri si distinguevano per
genialità e carisma, lui si comportava con la consueta arroganza
dell’aristocratico. Carenza che gli impedì di creare quell’empatia necessaria
per assicurare la necessaria coesione di un grande esercito”. G. Traina, Cit., pag.14.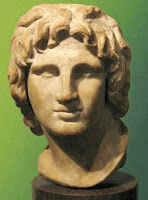 Stufo di sentirsi l’anello debole del
triumvirato che governa Roma dal 60 a.C., messo in piedi con gli altri due già
grandi condottieri, pensa di farsi strada ad Oriente dove prevede grandi
prospettive. In una mera logica espansionista possiamo ravvisare valide ragioni
strategiche per giustificare una guerra contro i Parti: il controllo della
Terra tra i due Fiumi da cui aprirsi le vie commerciali verso l’India e la
Cina. “Immaginava già di spingersi fino all’Estremo Oriente, nelle terre degli
indiani e dei battriani, ovvero ai confini di quelle immense regioni che solo
il grande Alessandro era riuscito a
conquistare”. G. Traina, Cit., p.17.
Stufo di sentirsi l’anello debole del
triumvirato che governa Roma dal 60 a.C., messo in piedi con gli altri due già
grandi condottieri, pensa di farsi strada ad Oriente dove prevede grandi
prospettive. In una mera logica espansionista possiamo ravvisare valide ragioni
strategiche per giustificare una guerra contro i Parti: il controllo della
Terra tra i due Fiumi da cui aprirsi le vie commerciali verso l’India e la
Cina. “Immaginava già di spingersi fino all’Estremo Oriente, nelle terre degli
indiani e dei battriani, ovvero ai confini di quelle immense regioni che solo
il grande Alessandro era riuscito a
conquistare”. G. Traina, Cit., p.17.
La mano destra e la testa mozzata,
“abbeverata” d’oro fuso per saziarne la sete di ricchezza finiranno ad ornare
un banchetto di re Orode come regalo di Surena.
CRONACA
SUL “VIETNAM” DEI ROMANI TRA ARCIERI E CAVALLERIA
 Plutarco
si è
occupato di tramandarci le sue cronache di guerra, crude ed efficaci anche
senza radio o Tv: “Raccolti in un piccolo spazio, venivano colpiti e cadevano
gli uni sugli altri, agonizzando lentamente, straziati da un dolore
insopportabile rotolavano sui dardi che si spezzavano dentro le ferite. Nello
sforzo di estrarre le punte, penetrate nelle vene e nei nervi e ripiegate come
un amo, essi finivano per distruggersi e dilaniarsi da sé. Così tanti morivano,
mentre i superstiti erano allo stremo delle forze…”. E così anche Cassio Dione: “Piombando in massa sui
romani da ogni parte, ne ferivano mortalmente parecchi, e parecchi
impossibilitavano a combattere, e nessuno poteva trovar pace. Infatti i dardi
sfrecciavano sugli occhi, sulle mani e su tutto il resto del corpo;
trapassavano le armature, li lasciavano senza protezione e, continuando a
ferirli, li costringevano a esporsi. Se qualcuno si difendeva dal dardo o
cercava di estrarlo, un altro lo colpiva e una ferita si aggiungeva all’altra.
Che si muovessero o restassero impassibili, non avevano via di scampo, poiché
entrambe le soluzioni erano insicure e portavano alla morte”.
Plutarco
si è
occupato di tramandarci le sue cronache di guerra, crude ed efficaci anche
senza radio o Tv: “Raccolti in un piccolo spazio, venivano colpiti e cadevano
gli uni sugli altri, agonizzando lentamente, straziati da un dolore
insopportabile rotolavano sui dardi che si spezzavano dentro le ferite. Nello
sforzo di estrarre le punte, penetrate nelle vene e nei nervi e ripiegate come
un amo, essi finivano per distruggersi e dilaniarsi da sé. Così tanti morivano,
mentre i superstiti erano allo stremo delle forze…”. E così anche Cassio Dione: “Piombando in massa sui
romani da ogni parte, ne ferivano mortalmente parecchi, e parecchi
impossibilitavano a combattere, e nessuno poteva trovar pace. Infatti i dardi
sfrecciavano sugli occhi, sulle mani e su tutto il resto del corpo;
trapassavano le armature, li lasciavano senza protezione e, continuando a
ferirli, li costringevano a esporsi. Se qualcuno si difendeva dal dardo o
cercava di estrarlo, un altro lo colpiva e una ferita si aggiungeva all’altra.
Che si muovessero o restassero impassibili, non avevano via di scampo, poiché
entrambe le soluzioni erano insicure e portavano alla morte”. Si verifica uno scontro con tattiche militari
che rinnovano le reciproche tradizioni: “I legionari romani equipaggiati con il
gladio e il giavellotto, ma queste armi potevano ben poco contro i rapidi
movimenti degli arcieri a cavallo e le pesanti corazze… Certo, i Romani
disponevano di un’efficacissima tattica, la formazione
a testuggine, che permetteva anche a grandi unità di formare un quadrato,
reso impenetrabile da una barriera formata dagli scudi ma questa tattica
appesantiva il movimento della legione, riducendone quindi le potenzialità
offensive… Provocare, ferire dalla distanza, eludere l’urto frontale, provocare
di nuovo, attirare lontano dalle proprie basi il nemico in uno spazio vasto e
ostile, inadatto alla concentrazione dello sforzo, a quel parossismo di
violenza risolutiva che è il combattimento in ordine chiuso: questi sono i
principi cui si devono uniformare la strategia e la tattica dell’arciere; se
gestiti in maniera appropriata, sono potenzialmente letali per le armi pesanti
tipiche dell’Occidente”. G. Traina, Cit.,
pp.69-72.
Si verifica uno scontro con tattiche militari
che rinnovano le reciproche tradizioni: “I legionari romani equipaggiati con il
gladio e il giavellotto, ma queste armi potevano ben poco contro i rapidi
movimenti degli arcieri a cavallo e le pesanti corazze… Certo, i Romani
disponevano di un’efficacissima tattica, la formazione
a testuggine, che permetteva anche a grandi unità di formare un quadrato,
reso impenetrabile da una barriera formata dagli scudi ma questa tattica
appesantiva il movimento della legione, riducendone quindi le potenzialità
offensive… Provocare, ferire dalla distanza, eludere l’urto frontale, provocare
di nuovo, attirare lontano dalle proprie basi il nemico in uno spazio vasto e
ostile, inadatto alla concentrazione dello sforzo, a quel parossismo di
violenza risolutiva che è il combattimento in ordine chiuso: questi sono i
principi cui si devono uniformare la strategia e la tattica dell’arciere; se
gestiti in maniera appropriata, sono potenzialmente letali per le armi pesanti
tipiche dell’Occidente”. G. Traina, Cit.,
pp.69-72.
Anche la guerra è un momento di studio e
analisi, una grande vittoria o una grande sconfitta possono aprire ad
evoluzioni rivoluzionarie nelle tecniche militari: “In questa occasione, le
armi di corta portata dei Romani e il loro sistema di ammassamento soggiacquero
per la prima volta alle armi di lunga portata ed al sistema di spiegare le
truppe in battaglia, cominciò quella rivoluzione militare, che poi con
l’introduzione dell’arma da fuoco, ebbe il suo pieno compimento… Le legioni
che, nonostante il suggerimento di ufficiali avveduti di condurle contro il
nemico quanto più possibile spiegate, erano state ordinate in un quadrato
composto di dodici coorti su ogni lato, furono subito sopraffatte e tempestate
dalle terribili frecce, che, lanciate anche a caso, colpivano le loro vittime,
e alle quali i soldati romani non potevano assolutamente rispondere in nessun
modo”. T. Mommsen, Storia di Roma,
Vol. VIII, p.16.
I Romani si espongono così agli avversari
come un bersaglio mobile senza possibilità di fuga o riparo: “Giunsero in vista
del nemico, che palesò solo alcuni contingenti, nascondendo il grosso dietro le
alture e coprendo il luccichio delle armi al sole con mantelli e pellami… Le
speranze che quella interminabile pioggia di frecce si esaurisse si spensero di
fronte alla notizia che un’intera carovana di cammelli, con riserve immense di
dardi, era disposta dietro le dune per rifornire gli arcieri a cavallo”. A.
Frediani, Cit., p.269.
UNA
PIOGGIA DI FRECCE CHE OSCURA IL SOLE
 Il disastro di Carre in lande desolate e
sconfinate dipende da una tattica che prevede l’uso combinato di arcieri e
cavalleria. La pressione dei primi blocca il margine di manovra delle legioni,
che ammassandosi nella ricerca istintiva di un riparo favoriscono l’attacco
irresistibile e micidiale dei cavalieri corazzati. Già Seneca evidenzia che “un bambino nato in Partia tenderà subito l’arco”,
così come si impratichiscono cavalcando le pecore.
Il disastro di Carre in lande desolate e
sconfinate dipende da una tattica che prevede l’uso combinato di arcieri e
cavalleria. La pressione dei primi blocca il margine di manovra delle legioni,
che ammassandosi nella ricerca istintiva di un riparo favoriscono l’attacco
irresistibile e micidiale dei cavalieri corazzati. Già Seneca evidenzia che “un bambino nato in Partia tenderà subito l’arco”,
così come si impratichiscono cavalcando le pecore. Ne deriva che i guerrieri mediterranei non
conoscono a sufficienza l’arco composto che può scoccare frecce ad una distanza
almeno doppia rispetto a quelli ellenistici e romani. Ne parla anche Plinio il Vecchio quando ricorda che:
“I popoli d’Oriente decidono le guerre con le canne. Applicandovi delle penne,
con esse arrecano una rapida morte; vi aggiungono punte uncinate mortali, che
non possono estrarre e si spezzano dentro la ferita, come un doppio strale. Con
queste armi possono oscurare il sole”. Ben diversa fino ad allora è
l’esperienza dei Romani la cui aura di invincibilità “era determinata dalla
grande esperienza accumulata nei teatri operativi di tutto il Mediterraneo:
dalla Spagna all’Africa, dal Balcani all’Asia Minore, la legione sembrava
destinata ad avere la meglio su qualsiasi terreno… Come già la falange
ellenistica, si serviva delle truppe montate: il nerbo dell’esercito era la
fanteria pesante legionaria, mentre i cavalieri rappresentavano un complemento
utile ma non decisivo”. G. Traina, Cit.,
p.23.
Ne deriva che i guerrieri mediterranei non
conoscono a sufficienza l’arco composto che può scoccare frecce ad una distanza
almeno doppia rispetto a quelli ellenistici e romani. Ne parla anche Plinio il Vecchio quando ricorda che:
“I popoli d’Oriente decidono le guerre con le canne. Applicandovi delle penne,
con esse arrecano una rapida morte; vi aggiungono punte uncinate mortali, che
non possono estrarre e si spezzano dentro la ferita, come un doppio strale. Con
queste armi possono oscurare il sole”. Ben diversa fino ad allora è
l’esperienza dei Romani la cui aura di invincibilità “era determinata dalla
grande esperienza accumulata nei teatri operativi di tutto il Mediterraneo:
dalla Spagna all’Africa, dal Balcani all’Asia Minore, la legione sembrava
destinata ad avere la meglio su qualsiasi terreno… Come già la falange
ellenistica, si serviva delle truppe montate: il nerbo dell’esercito era la
fanteria pesante legionaria, mentre i cavalieri rappresentavano un complemento
utile ma non decisivo”. G. Traina, Cit.,
p.23.
Carre è dunque un completo capovolgimento dei
principali sistemi tecnici e tattici con cui fino ad allora i Romani hanno piegato
ogni nemico. Infatti, si tramuta anche in guerra
psicologica; mentre con le legioni si è sempre affidato alla vista di
enormi schieramenti il compito di influire sul morale dei combattenti, i Parti
puntano sull’udito: “A Carre prevalsero invece i tamburi di guerra… Impeto,
esaltazione, canto animalesco e ululati, furore, ebbrezza: per non parlare
dello strumento sciamanico per eccellenza, il tamburo e i sonagli adoperati
nella guerriglia psicologica che tanta parte ebbe nella sconfitta dell’esercito
di Crasso… Anziché attaccare subito la legione si decise di continuare a
stancare il nemico con gli arcieri leggeri, e di ordinare la carica al momento
opportuno”. G. Traina, Cit., pp.74-81.
Insomma una battaglia che si esplica con un
modo di combattere insolito tra eserciti totalmente diversi per armamenti e
formazione. Come si potrebbe sintetizzare raccogliendo qui e là analisi di
studiosi moderni, è possibile affermare che “il modo di combattere degli uomini
di Surena ricorda una banda di ragazzi fuorviati, senza fede né legge, che
praticavano una guerra di folgoranti colpi di mano, logorando la preda fino
alla morte, per perdersi subito dopo nell’immensità delle distese desertiche”.
Se ne può trarre che “un’idea diffusa degli storici è che, dopo Carre, il modo
di combattere dei romani sia cambiato. Di certo si dotarono di armi più
efficaci, migliorando la qualità delle corazze, e dei giavellotti… I generali
appresero una grande lezione di tattica, che misero in pratica per difendersi
dai parti, e probabilmente anche per ispirarsene”. G. Traina, Cit., p.102.
DUE IMPERI
UN SOLO IMPERO
 Carre come battuta d’arresto per Roma, tanto
che lo scenario storico presenterà effettivamente due blocchi separati
dall’Eufrate. In definitiva due aree egemoniche, due imperi: il Mediterraneo
romano e l’Asia partica (Iran, Iraq, Armenia, parte del Caucaso ed Asia
centrale). Come riporta Strabone: “I
Parti oggi dominano un territorio così grande, e così tanti popoli, da
rivaleggiare in qualche modo con i romani per la grandezza del dominio. Causa
di questo successo sono il loro stile di vita e i costumi: certo, essi hanno
molti elementi comuni con i barbari e con gli sciti, e tuttavia presentano
quanto occorre per dominare e per vincere in guerra”.
Carre come battuta d’arresto per Roma, tanto
che lo scenario storico presenterà effettivamente due blocchi separati
dall’Eufrate. In definitiva due aree egemoniche, due imperi: il Mediterraneo
romano e l’Asia partica (Iran, Iraq, Armenia, parte del Caucaso ed Asia
centrale). Come riporta Strabone: “I
Parti oggi dominano un territorio così grande, e così tanti popoli, da
rivaleggiare in qualche modo con i romani per la grandezza del dominio. Causa
di questo successo sono il loro stile di vita e i costumi: certo, essi hanno
molti elementi comuni con i barbari e con gli sciti, e tuttavia presentano
quanto occorre per dominare e per vincere in guerra”. Nonostante questo preferisce fermarsi e dedicarsi all’organizzazione delle
nuove province: “Il conquistatore fu tentato di imitare Alessandro, inseguendo
l’avversario come il macedone aveva inseguito Dario; ma fino ad allora era andato tutto bene, e mettere alla
prova la resistenza dell’esercito in una dura marcia attraverso gli altipiani
iranici era una prospettiva assai poco allettante. Quanto appariva opportuno
per confermare il prestigio di Roma e la sua fama di condottiero era già stato
attuato”. A. Frediani, Cit., p.455.
Nonostante questo preferisce fermarsi e dedicarsi all’organizzazione delle
nuove province: “Il conquistatore fu tentato di imitare Alessandro, inseguendo
l’avversario come il macedone aveva inseguito Dario; ma fino ad allora era andato tutto bene, e mettere alla
prova la resistenza dell’esercito in una dura marcia attraverso gli altipiani
iranici era una prospettiva assai poco allettante. Quanto appariva opportuno
per confermare il prestigio di Roma e la sua fama di condottiero era già stato
attuato”. A. Frediani, Cit., p.455.  Da quel momento il regno partico si avvia
verso la scomparsa intorno al 224 d.C. a causa di distruttivi conflitti
feudali. Roma no, continua con le sue profonde evoluzioni ad influenzare ogni
pagina di storia successiva nell’accavallarsi del tempo. Sopravvive perché la
struttura statale diluisce in qualche modo l’ambizione del singolo, con il
risultato che l’Impero si occupa di gestire il potere e il dominio contro
l’avventurismo fine a se stesso. Nessun condottiero eguaglierà Alessandro, ma
in questo ricorrente richiamo Tito Livio
sottolinea “l’assurdità di un raffronto tra le gesta di un singolo giovane re
conquistatore e quelle di un popolo che fa la guerra da ben ottocento anni… I
macedoni avevano un solo Alessandro, che non soltanto si esponeva a molteplici
pericoli ma lo faceva di sua spontanea volontà. Invece molti erano i romani che
potevano emularlo per gloria e imprese. Ciascuno di essi, a seconda del proprio
destino, avrebbe potuto vivere o morire senza che per questo la repubblica
corresse alcun rischio”. Insomma mentre i regni ellenistici si sfasciano dopo
una sola disfatta, Roma continua a vivere anche sul cadavere di un Crasso.
Da quel momento il regno partico si avvia
verso la scomparsa intorno al 224 d.C. a causa di distruttivi conflitti
feudali. Roma no, continua con le sue profonde evoluzioni ad influenzare ogni
pagina di storia successiva nell’accavallarsi del tempo. Sopravvive perché la
struttura statale diluisce in qualche modo l’ambizione del singolo, con il
risultato che l’Impero si occupa di gestire il potere e il dominio contro
l’avventurismo fine a se stesso. Nessun condottiero eguaglierà Alessandro, ma
in questo ricorrente richiamo Tito Livio
sottolinea “l’assurdità di un raffronto tra le gesta di un singolo giovane re
conquistatore e quelle di un popolo che fa la guerra da ben ottocento anni… I
macedoni avevano un solo Alessandro, che non soltanto si esponeva a molteplici
pericoli ma lo faceva di sua spontanea volontà. Invece molti erano i romani che
potevano emularlo per gloria e imprese. Ciascuno di essi, a seconda del proprio
destino, avrebbe potuto vivere o morire senza che per questo la repubblica
corresse alcun rischio”. Insomma mentre i regni ellenistici si sfasciano dopo
una sola disfatta, Roma continua a vivere anche sul cadavere di un Crasso.
















